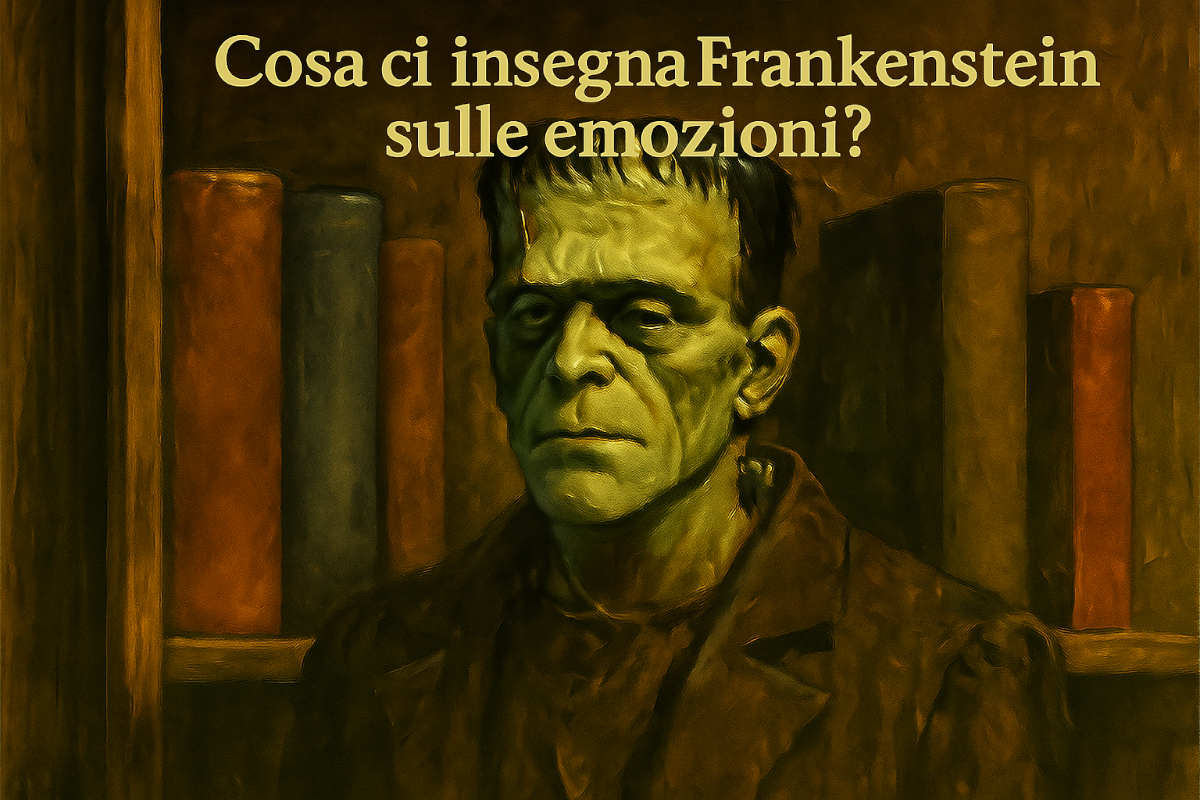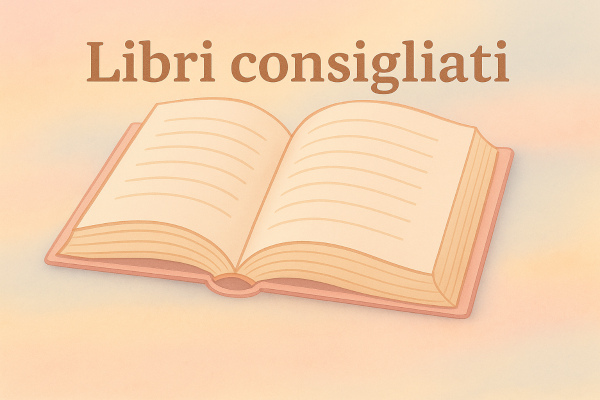Mary Shelley aveva diciannove anni quando scrisse Frankenstein durante l’estate del 1818 sul lago di Ginevra. Sfidò Lord Byron e Percy Shelley a scrivere una storia di fantasmi e da quella sfida nacque qualcosa di inaspettato: non solo il primo romanzo di fantascienza ma anche una delle analisi più crude su come la solitudine trasforma le persone.
La solitudine che diventa violenza
Victor Frankenstein e la sua creatura sono due solitari che reagiscono diversamente al loro isolamento. Victor si chiude nel laboratorio, ossessionato dalla scienza. La creatura si ritrova buttata in un mondo che la respinge. Shelley ci mostra che la solitudine, quando è totalizzante, non è mai neutra: o ci distrugge dall’interno o ci trasforma in distruttori.
La creatura non nasce cattiva. Quando prende vita, osserva il mondo con curiosità, impara il linguaggio ascoltando una famiglia di contadini, si commuove leggendo I dolori del giovane Werther. Ma ogni tentativo di avvicinamento agli esseri umani si trasforma in una fuga piena di terrore. La sensibilità che dovrebbe renderla più umana diventa la sua condanna.
“Sono malvagio perché sono infelice”, dice al suo creatore.
È una frase che contiene una verità scomoda: quando il nostro bisogno di appartenenza viene continuamente frustrato, il dolore può trasformarsi in rabbia distruttiva. Questa, ovviamente, non è una giustificazione ma solo la spiegazione di come funziona la psiche umana quando viene respinta troppo spesso.
Victor e la sua cecità emotiva
Victor Frankenstein è un genio della scienza e un disastro come essere umano. Riesce a dare vita alla materia morta ma è completamente cieco di fronte alle conseguenze emotive delle sue azioni. Crea un essere senziente e lo abbandona subito, disgustato dal suo aspetto. Non si chiede mai cosa possa provare la sua creatura, quali siano i suoi bisogni, le sue emozioni.
Questa cecità emotiva attraversa tutto il romanzo. Victor sa chi ha ucciso il fratello William ma lascia che l’innocente Justine venga giustiziata. Quando la creatura gli chiede una compagna, Victor inizia a crearla ma poi la distrugge, ancora una volta senza considerare l’impatto di questo gesto sul suo “figlio” artificiale.
Victor rappresenta l’intelligenza senza saggezza emotiva. È talmente concentrato sul “posso farlo” che non si chiede mai “dovrei farlo” o “cosa succederà dopo”. La sua brillantezza scientifica, senza la capacità di riconoscere e gestire le emozioni, diventa letale.
Vuoi allenare o migliorare la tua intelligenza emotiva?
Scopri i migliori libri che ti aiutano a svilupparla.
Il bisogno di essere accettati
Ciò che colpisce di più in Frankenstein è come Shelley abbia saputo rappresentare il nostro bisogno più basilare: sentirci accettati per quello che siamo. La creatura vuole disperatamente far parte di una comunità, avere una famiglia, essere riconosciuta come essere senziente degno di compassione. Quando questo bisogno viene negato, si trasforma in qualcosa di mostruoso – non per natura, ma per circostanza.
L’autrice ci fa vedere come l’esclusione sociale possa essere mortale. La creatura diventa un assassino non per cattiveria innata ma perché l’isolamento e il rifiuto costante hanno corroso la sua capacità di provare empatia. Shelley ci fa vedere quanto possa essere dannoso escludere qualcuno dalla nostra cerchia di compassione.
Cosa possiamo imparare oggi da Frankenstein?
Frankenstein ci fa riflettere su come funzionano le emozioni. In particolare ci insegna che:
- Le nostre azioni hanno sempre conseguenze emotive. Come Victor, spesso agiamo senza considerare l’impatto emotivo che abbiamo sugli altri. Un commento tagliente, una promessa non mantenuta, un gesto di esclusione – tutto ha un peso emotivo. Fermarsi e chiedersi “Come si sentirà l’altra persona?” può cambiare completamente il corso di una relazione.
- Dietro l’aggressività c’è spesso dolore. Quando qualcuno si comporta in modo distruttivo, la nostra prima reazione è il giudizio. Ma la creatura di Frankenstein ci ricorda che dietro la rabbia si nasconde spesso un dolore profondo e non riconosciuto. Questo non giustifica affatto i comportamenti dannosi ma ci aiuta a comprendere meglio come funziona la rabbia e a rispondere con maggiore saggezza.
- L’inclusione ha un potere enorme. Il romanzo ci mostra quanto sia potente il senso di appartenenza. Quando facciamo sentire qualcuno visto e accettato, stiamo nutrendo la parte migliore della natura umana. L’esclusione, al contrario, può essere devastante.
- L’ambizione senza umanità è pericolosa. Victor è così focalizzato sul suo obiettivo scientifico che perde di vista le persone intorno a lui. Nella vita quotidiana, questo si traduce nel rischio di essere così concentrati sui nostri obiettivi da dimenticare l’impatto emotivo delle nostre scelte.
Restiamo in contatto! 🧡🧠
Segui Intelligenza-emotiva.it sui canali social per non perderti i nuovi articoli!
L’incomprensione che uccide
La tragedia più grande di Frankenstein è l’incomprensione reciproca. Victor e la sua creatura non riescono mai a vedersi veramente. Victor vede solo un mostro, la creatura vede solo un padre crudele. Entrambi sono intrappolati nelle loro percezioni e nei loro dolori, incapaci di quel passo empatico che potrebbe salvare tutti.
Questo ci fa pensare a quanto sia importante coltivare la curiosità emotiva verso gli altri. Quando qualcuno ci appare “mostruoso” o incomprensibile, forse stiamo guardando solo la superficie. Come la creatura di Frankenstein, anche le persone più difficili hanno spesso una storia di dolore e di bisogni non soddisfatti.
Un romanzo che ci guarda
Leggendo Frankenstein oggi è difficile non riconoscere alcune delle nostre paure in quelle pagine: il terrore di essere rifiutati, di rimanere soli, di non essere compresi.
La prossima volta che incontriamo qualcuno che ci sembra “mostruoso” – un collega difficile, un vicino scontroso o anche noi stessi nei nostri momenti peggiori – potremmo provare per esempio a chiederci: quale dolore si nasconde dietro questa facciata? Quale bisogno non soddisfatto sta guidando questo comportamento? Non sempre avremo le risposte ma già il fatto di porci queste domande ci rende più umani.
Mary Shelley ci ha lasciato in eredità con questo romanzo qualcosa di scomodo: la comprensione che la vera mostruosità non sta nell’aspetto o nella diversità ma nell’incapacità di riconoscere e accogliere l’umanità dell’altro.